di Francesco Venturini, medico psicoterapeuta e formatore Kaloi
Capita a tutti di desiderare il raggiungimento di un obiettivo o la realizzazione di uno scopo. E quando obiettivi e scopi vengono raggiunti, possono anche portare ad un miglioramento della qualità della vita. Gli obiettivi possono interessare vari ambiti dell’esistenza di una persona: traguardi di studio, obiettivi professionali, il miglioramento della propria salute, il raggiungimento di una buona prestazione sportiva e così via. Spesso però i desideri… restano desideri e a questi si sostituisce il rimpianto per non essere riusciti a realizzarli. L’incapacità di realizzazione può essere dovuta ad una sensazione di sfiducia nella propria persona e nelle proprie capacità, spesso anche per la presenza di convinzioni “limitanti” che ostacolano l’intraprendenza nell’agire e che possono risalire all’età giovanile. Molte persone infatti riescono a riconoscere nel fondo del proprio animo la presenza di un sottile sentimento di autosvalutazione, di sensazione di doversi accontentare, di essere esclusi dal “gioco” perché… non si è bravi abbastanza o capaci come gli altri. Questo sentimento può contribuire a far nascere un senso di sfiducia e di “impotenza appresa”.
 Riuscire a “sganciarsi” da questo costrutto e cominciare ad “osare” sono i primi passi da muovere per riuscire a raggiungere un obiettivo. Quindi, se abbiamo un desiderio di miglioramento nella nostra vita non indugiamo troppo nel rimuginare ma cominciamo ad agire con determinazione!
Riuscire a “sganciarsi” da questo costrutto e cominciare ad “osare” sono i primi passi da muovere per riuscire a raggiungere un obiettivo. Quindi, se abbiamo un desiderio di miglioramento nella nostra vita non indugiamo troppo nel rimuginare ma cominciamo ad agire con determinazione!
Per riuscirci dobbiamo all’inizio cercare di capire quali sono i pensieri che ostacolano l’entrata in azione dei nostri comportamenti efficaci, tenendo presente che spesso non è facile comprendere quali siano e come determinino il nostro stato d’animo, perplesso nell’agire se non sfiduciato già in partenza. Con un lavoro personale, fatto anche di riflessioni, di letture, di partecipazione a gruppi o con l’aiuto di un professionista è possibile disinnescare queste convinzioni limitanti ed avviarsi verso il successo.
Infatti, per giungere a questo non è solo importante avere una buona autostima ma serve anche una buona Autoefficacia; essa consiste nel saper padroneggiare le abilità e le competenze che servono per giungere al risultato voluto, ma anche a poter superare situazioni difficili che la vita a volte presenta.
Per Autoefficacia intendiamo la convinzione di poter fronteggiare e affrontare efficacemente certe prove, di sentirsi all’altezza di superare determinati eventi, di affrontare dei compiti specifici e soprattutto di essere capaci di impegnarsi a fondo in quelle attività che permettano di raggiungere lo scopo: quanto più si è capaci di influenzare gli eventi tanto più si riesce ad influire sul percorso che può portare al risultato desiderato. Lo psicologo americano Albert Bandura ha introdotto il termine Autoefficacia, definendola come “la convinzione di essere in grado di organizzare e realizzare le azioni per gestire adeguatamente le situazioni che si incontrano in un particolare contesto in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati” e anche “le convinzioni circa le proprie capacità di organizzare ed eseguire le sequenze di azioni necessarie per produrre determinati risultati”.
L’Autoefficacia è dunque quella dimensione della personalità che permette all’individuo di porsi dei traguardi, di perseguire il loro raggiungimento con azioni appropriate e di riuscire ad automotivarsi per raggiungere lo scopo. Tutto questo richiede la capacità di coltivare l’autocontrollo e l’autoregolazione. Il “senso di Autoefficacia” risulta utile soprattutto nelle situazioni nuove o complesse, che possono anche portare a cambiamenti positivi nella vita: saper affrontare adeguatamente questi frangenti richiede il conoscere le abilità che si possiedono, sapere come fare ma soprattutto essere convinti di poterle utilizzare al meglio.
 Essere Autoefficaci non significa infatti possedere un numero notevole di competenze, ma essere capaci di utilizzare efficacemente le competenze possedute, anche se in quantità ridotta. Essere consapevoli della propria Autoefficacia ha anche un’influenza sugli obiettivi che le persone vogliono perseguire: tanto più sono convinte delle proprie capacità (cioè tanto maggiore è il loro senso di Autoefficacia), tanto più saranno importanti gli obiettivi che sceglieranno. Non solo: sarà maggiore anche la perseveranza e la tenacia con cui porteranno a compimento l’azione. Sotto questo punto di vista, l’Autoefficacia aumenta l’Autostima in un circolo virtuoso.
Essere Autoefficaci non significa infatti possedere un numero notevole di competenze, ma essere capaci di utilizzare efficacemente le competenze possedute, anche se in quantità ridotta. Essere consapevoli della propria Autoefficacia ha anche un’influenza sugli obiettivi che le persone vogliono perseguire: tanto più sono convinte delle proprie capacità (cioè tanto maggiore è il loro senso di Autoefficacia), tanto più saranno importanti gli obiettivi che sceglieranno. Non solo: sarà maggiore anche la perseveranza e la tenacia con cui porteranno a compimento l’azione. Sotto questo punto di vista, l’Autoefficacia aumenta l’Autostima in un circolo virtuoso.
La fiducia nelle proprie capacità ha dei risvolti positivi anche sul senso di controllo in diversi fronti personali: dal controllo delle emozioni, dei comportamenti in famiglia, sul lavoro, sul miglioramento della propria salute, fino a riuscire a trasformare situazioni da sfavorevoli in favorevoli. L’avere una buona efficacia personale porta ad un benessere psicologico e fisico, al successo professionale, al saper attuare strategie di cambiamento.
Possiamo delineare due tipi di persone: quelle che hanno una bassa Autoefficacia e quelle che invece l’hanno alta.
Le persone che hanno un basso senso di Autoefficacia hanno basse aspirazioni e si accontentano di quello che già possiedono, cercano di evitare i compiti difficili perché si sentono incapaci di affrontarli e portarli a termine, non riescono a cogliere le opportunità che la vita propone e rinunciano facilmente quando incontrano delle difficoltà. In questi casi, un lavoro personale può essere rivolto a rinforzare la persona stessa e il suo senso di efficacia con appositi interventi psicoterapici.
Diverso è l’approccio alla vita di chi possiede un’alta Autoefficacia: innanzitutto si sente capace di controllare quello che succede e ha alte aspirazioni. Quando si pone un obiettivo persevera per raggiungerlo ed è capace di affrontare gli stressors che la vita gli pone davanti. Non solo: in presenza di ostacoli raddoppia l’impegno e non si abbatte facilmente. Infine, ma non ultimo, viene poco colpito dalla depressione.
Ottimismo e Autoefficacia sono legati: la persona ottimista vede più ampliate le proprie possibilità e capacità; inoltre, sia l’ottimismo che l’Autoefficacia orientano l’individuo al benessere, essendo questo dipendente anche da una visione positiva della vita. Cominciare a prendere in considerazione le proprie credenze di efficacia, dopo aver modificato le credenze limitanti, porta a una migliore conoscenza di sé e delle proprie caratteristiche positive. Fa definire i punti di forza della persona stessa e la spinge verso il cambiamento.
Le persone dotate di un buon senso di autoefficacia possiedono delle caratteristiche:
– individuano obiettivi realistici da raggiungere per migliorare la loro situazione;
– hanno fiducia nelle proprie capacità;
– sono convinte della possibilità di ottenere un successo;
– si attivano per raggiungere uno scopo e ricercano sostegno sociale.

La capacità di essere autoefficaci può essere sviluppata e aumentata seguendo queste 5 regole :
1 – Sentirsi padroni delle proprie competenze. È la qualità più potente: essere consapevoli delle proprie capacità, oltre ad aumentare l’autostima, rende più sicuri di sé, fiduciosi nelle possibilità di raggiungere un obiettivo o di attuare un cambiamento e poi mantenerlo.
2 – Trovare degli esempi di persone che possono aiutare il rinforzo delle azioni. È questo il cosiddetto processo di “modeling”, secondo il quale il comportamento può essere “modellato” sull’esempio di persone che hanno vissuto le stesse esperienze o difficoltà superandole con successo.
3 – Rivedere il significato attribuito agli eventi. Spesso per motivi culturali o per una visione pessimistica dell’esistenza gli accadimenti della vita sono vissuti in modo passivo e quasi fatalistico, senza scorgere in essi la possibilità ad un cambiamento positivo.
4 – Lavorare su se stessi con la persuasione. Il consolidamento del senso di autoefficacia avviene anche con un’opera di convincimento esercitata su se stessi, allo scopo di aumentare la perseveranza, rinsaldare le proprie decisioni ed evitare cedimenti.
5 – Sapere gestire gli stati affettivi negativi. Anche trasformandoli in occasioni di crescita e cambiamento in meglio. La persona consapevole della propria autoefficacia può affrontare con una prospettiva diversa anche avvenimenti logoranti e momenti difficili perché in se stessa sa ritrovare risorse per superarli.
Non dimenticando che l’uomo è un “animale sociale” e ha bisogno dei suoi simili, coltivare l’Autoefficacia vuol dire essere capaci di autoregolazione. E questa porta ad esiti vincenti!
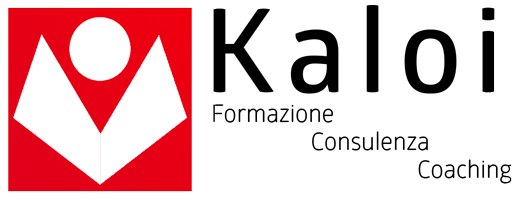
 A chi ha la buona abitudine di leggere quotidiani o articoli sul web non sarà sfuggito il recente sondaggio, presentato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto, in cui i cittadini della regione si sono espressi a favore della presenza permanente della figura dello psicologo all’interno delle scuole (oltre il 60% degli intervistati). Così, visto che qualsiasi notizia che contenga la parola SCUOLA accende in me una irrefrenabile curiosità (e, diciamocelo, anche una trepidante speranza in un suo futuro migliore), mi sono resa conto che questi articoli si prestavano a farmi riflettere su più fronti: da una parte sono felice che la scuola sia un tema “sulla bocca” di molti e che si ritorni a pensare e a valutare quali siano le necessità di un’istituzione spesso bistrattata dai politici di turno e da una società che non ripone più in essa le proprie speranze (anzi, spesso la vede come un contenitore in cui scaricare le proprie “colpe”); dall’altra parte, però, mi ritrovo, da pedagogista ed ex insegnante, a pensare a quanto il mondo della scuola stia perdendo la bussola che l’ha sempre fatta navigare in mari più o meno tempestosi: l’educazione.
A chi ha la buona abitudine di leggere quotidiani o articoli sul web non sarà sfuggito il recente sondaggio, presentato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto, in cui i cittadini della regione si sono espressi a favore della presenza permanente della figura dello psicologo all’interno delle scuole (oltre il 60% degli intervistati). Così, visto che qualsiasi notizia che contenga la parola SCUOLA accende in me una irrefrenabile curiosità (e, diciamocelo, anche una trepidante speranza in un suo futuro migliore), mi sono resa conto che questi articoli si prestavano a farmi riflettere su più fronti: da una parte sono felice che la scuola sia un tema “sulla bocca” di molti e che si ritorni a pensare e a valutare quali siano le necessità di un’istituzione spesso bistrattata dai politici di turno e da una società che non ripone più in essa le proprie speranze (anzi, spesso la vede come un contenitore in cui scaricare le proprie “colpe”); dall’altra parte, però, mi ritrovo, da pedagogista ed ex insegnante, a pensare a quanto il mondo della scuola stia perdendo la bussola che l’ha sempre fatta navigare in mari più o meno tempestosi: l’educazione. Ciò che è certo è che la Pedagogia non ha atteso un Decreto per operare laddove vi è più bisogno di lei: la scuola! Una scuola che al giorno d’oggi si trova davvero in una situazione di emergenza educativa e i numerosi fatti di cronaca ne sono la dimostrazione (accanto ad alunni con disabilità, vediamo il dilagare di episodi di bullismo, le difficoltà di alunni con disturbi dell’apprendimento, ADHD, svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e l’altalenante integrazione di studenti stranieri). Insomma, la scuola è davvero messa a dura prova! Ma possiamo anche dire che la scuola nasce proprio da e per questo: se tutto fosse facile, se esistessero solo studenti “perfetti” (utopia fortunatamente irraggiungibile!) non avrebbe motivo di esistere, visto che l’ideale educativo che persegue per sua natura è quello di creare, per dirla alla Lombardo Radice, “personalità umane complete ed originali”. Questo sarà possibile solo se la scuola spalancherà le porte alla pedagogia, quotidianamente, senza grosse rivoluzioni, ma compiendo piccoli passi, giorno dopo giorno, verso la comprensione dei reali bisogni formativi di bambini e ragazzi, bisogni che sono in continua evoluzione, travolti dai vorticosi cambiamenti sociali, economici, culturali, digitali… generazionali!
Ciò che è certo è che la Pedagogia non ha atteso un Decreto per operare laddove vi è più bisogno di lei: la scuola! Una scuola che al giorno d’oggi si trova davvero in una situazione di emergenza educativa e i numerosi fatti di cronaca ne sono la dimostrazione (accanto ad alunni con disabilità, vediamo il dilagare di episodi di bullismo, le difficoltà di alunni con disturbi dell’apprendimento, ADHD, svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e l’altalenante integrazione di studenti stranieri). Insomma, la scuola è davvero messa a dura prova! Ma possiamo anche dire che la scuola nasce proprio da e per questo: se tutto fosse facile, se esistessero solo studenti “perfetti” (utopia fortunatamente irraggiungibile!) non avrebbe motivo di esistere, visto che l’ideale educativo che persegue per sua natura è quello di creare, per dirla alla Lombardo Radice, “personalità umane complete ed originali”. Questo sarà possibile solo se la scuola spalancherà le porte alla pedagogia, quotidianamente, senza grosse rivoluzioni, ma compiendo piccoli passi, giorno dopo giorno, verso la comprensione dei reali bisogni formativi di bambini e ragazzi, bisogni che sono in continua evoluzione, travolti dai vorticosi cambiamenti sociali, economici, culturali, digitali… generazionali!
 Il rischio che qualche genitore, il 14 febbraio, porti a casa un mazzo di roselline al figlio e non al partner c’è. Anzi, ormai è cronaca quotidiana. Parola di fioristi!
Il rischio che qualche genitore, il 14 febbraio, porti a casa un mazzo di roselline al figlio e non al partner c’è. Anzi, ormai è cronaca quotidiana. Parola di fioristi!
 Qui c’è la chiave di volta; concedetemi allora un gioco di parole: fare il suo bene è diverso da volergli bene. Voler bene è importante, certo! E normalmente ci viene facile. Quando “ci si vuole bene” c’è una reciprocità in quell’affetto che fa star bene anche noi adulti. Fa stare ‘al caldo’. Chi, come me, ha figli già più grandini, ricorda con nostalgia il piacere di un abbraccio con il proprio cucciolo di 2 o 3 anni. O i dolci disegni portati a casa per la festa della mamma a 4 o 5 anni! Fare il bene del figlio è assai più complesso, a volte sembra dissonante con l’idea di amore. Ma è amore anche questo, anzi è la FORMA DI AMORE PIU’ DIFFICILE: quella che lavora per PROMUOVERE LE AUTONOMIE in un figlio, per esempio. Insistendo perché lui si vesta da solo, si lavi da solo, dorma da solo, studi da solo.
Qui c’è la chiave di volta; concedetemi allora un gioco di parole: fare il suo bene è diverso da volergli bene. Voler bene è importante, certo! E normalmente ci viene facile. Quando “ci si vuole bene” c’è una reciprocità in quell’affetto che fa star bene anche noi adulti. Fa stare ‘al caldo’. Chi, come me, ha figli già più grandini, ricorda con nostalgia il piacere di un abbraccio con il proprio cucciolo di 2 o 3 anni. O i dolci disegni portati a casa per la festa della mamma a 4 o 5 anni! Fare il bene del figlio è assai più complesso, a volte sembra dissonante con l’idea di amore. Ma è amore anche questo, anzi è la FORMA DI AMORE PIU’ DIFFICILE: quella che lavora per PROMUOVERE LE AUTONOMIE in un figlio, per esempio. Insistendo perché lui si vesta da solo, si lavi da solo, dorma da solo, studi da solo.
 “Ci risiamo. Ogni volta la stessa storia!” è il grido funesto di un genitore alle prese con l’ennesima ramanzina. Sembra ci sia un sottile sadismo, da parte dei bambini, nel far rimbalzare come una gomma ogni richiesta avanzata dal mondo adulto. Sono sicuro che molti tra noi sono convinti che i bambini scelgano sempre il momento meno opportuno, ci sfidino, vogliano mettere a dura prova la nostra pazienza.
“Ci risiamo. Ogni volta la stessa storia!” è il grido funesto di un genitore alle prese con l’ennesima ramanzina. Sembra ci sia un sottile sadismo, da parte dei bambini, nel far rimbalzare come una gomma ogni richiesta avanzata dal mondo adulto. Sono sicuro che molti tra noi sono convinti che i bambini scelgano sempre il momento meno opportuno, ci sfidino, vogliano mettere a dura prova la nostra pazienza. Non abbiamo il coraggio di riconoscere i limiti, oggettivi e soggettivi che viviamo in quanto esseri vulnerabili, cui nessuno ha mai insegnato come si educa un altro individuo in carne ed ossa. Non riusciamo ad ammettere che gli spazi di disponibilità da parte del mondo adulto si sono drasticamente ridotti. Che i frammenti di tempo che abbiamo a disposizione non vengono più investiti in momenti familiari utili a costituire i ricordi infantili dei nostri figli una volta divenuti adulti. Il tempo dell’educare è predato dalle incombenze del vivere e dalla spoglia superficialità del sopravvivere. È vero, c’è il lavoro e l’esigenza di garantire le risorse necessarie alla crescita dei nostri figli. Un tempo produttivo che ormai si espande oltre il terzo della giornata e che ci richiama continuamente alla necessità e alla logica delle emergenze. Queste ultime, sempre più numerose, rischiano di trasformare l’eccezione in ordinarietà. Rischiano di sostituire la pianificazione e la progettualità educativa con formule alla buona, traballanti, derivate dal senso comune o dall’ultimo best seller di Lucia Rizzo (s.o.s. Tata). Ciò che resta da questa sottrazione di senso sembra essere inghiottito dall’universo dell’Entertainment con i suoi inviti rassicuranti, seduttivi, al limite della banalità e riconducibili al trinomio: sesso, morte e denaro.
Non abbiamo il coraggio di riconoscere i limiti, oggettivi e soggettivi che viviamo in quanto esseri vulnerabili, cui nessuno ha mai insegnato come si educa un altro individuo in carne ed ossa. Non riusciamo ad ammettere che gli spazi di disponibilità da parte del mondo adulto si sono drasticamente ridotti. Che i frammenti di tempo che abbiamo a disposizione non vengono più investiti in momenti familiari utili a costituire i ricordi infantili dei nostri figli una volta divenuti adulti. Il tempo dell’educare è predato dalle incombenze del vivere e dalla spoglia superficialità del sopravvivere. È vero, c’è il lavoro e l’esigenza di garantire le risorse necessarie alla crescita dei nostri figli. Un tempo produttivo che ormai si espande oltre il terzo della giornata e che ci richiama continuamente alla necessità e alla logica delle emergenze. Queste ultime, sempre più numerose, rischiano di trasformare l’eccezione in ordinarietà. Rischiano di sostituire la pianificazione e la progettualità educativa con formule alla buona, traballanti, derivate dal senso comune o dall’ultimo best seller di Lucia Rizzo (s.o.s. Tata). Ciò che resta da questa sottrazione di senso sembra essere inghiottito dall’universo dell’Entertainment con i suoi inviti rassicuranti, seduttivi, al limite della banalità e riconducibili al trinomio: sesso, morte e denaro.
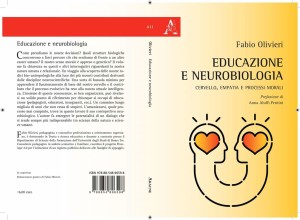
 Scuola dell’infanzia, un giorno come un altro. È il momento dell’uscita, e nel giro di un quarto d’ora mamme, papà, nonne e babysitter si affacciano alla porta dell’aula; i bimbi sono seduti in cerchio, e quando arriva il loro turno si alzano, vanno loro incontro, salutano la maestra, e corrono verso l’uscita.
Scuola dell’infanzia, un giorno come un altro. È il momento dell’uscita, e nel giro di un quarto d’ora mamme, papà, nonne e babysitter si affacciano alla porta dell’aula; i bimbi sono seduti in cerchio, e quando arriva il loro turno si alzano, vanno loro incontro, salutano la maestra, e corrono verso l’uscita. Sergio (nome di fantasia), sembra piuttosto arrabbiato, col visetto imbronciato e lo sguardo rivolto a terra. Si appoggia alla mamma, e da principio mi sembra quasi mortificato. Ma quando la maestra gli fa notare che con il suo gesto, oltre ad aver trasgredito a una regola, ha fatto male alla compagna, e dovrebbe chiederle scusa, alza gli occhi e risponde con voce sicura: “No!”
Sergio (nome di fantasia), sembra piuttosto arrabbiato, col visetto imbronciato e lo sguardo rivolto a terra. Si appoggia alla mamma, e da principio mi sembra quasi mortificato. Ma quando la maestra gli fa notare che con il suo gesto, oltre ad aver trasgredito a una regola, ha fatto male alla compagna, e dovrebbe chiederle scusa, alza gli occhi e risponde con voce sicura: “No!” Cosa significa “mio figlio è fatto così!”? Cosa spinge un genitore a pronunciare queste parole? Quali i sentimenti, le intenzioni?
Cosa significa “mio figlio è fatto così!”? Cosa spinge un genitore a pronunciare queste parole? Quali i sentimenti, le intenzioni? Anche se a volte il confine è molto sottile, accettare, ascoltare, comprendere non significano giustificare. Che è proprio ciò che ha fatto la mamma di Sergio: ha giustificato l’azione del figlio; non la sua fatica a chiedere scusa, non la sua rabbia, ma il suo usare la forza e picchiare gli altri bambini quando “gli saltano i cinque minuti”: io lo accetto così com’è, e anche gli altri lo devono accettare, compreso chi si becca il suo bicchiere in fronte!
Anche se a volte il confine è molto sottile, accettare, ascoltare, comprendere non significano giustificare. Che è proprio ciò che ha fatto la mamma di Sergio: ha giustificato l’azione del figlio; non la sua fatica a chiedere scusa, non la sua rabbia, ma il suo usare la forza e picchiare gli altri bambini quando “gli saltano i cinque minuti”: io lo accetto così com’è, e anche gli altri lo devono accettare, compreso chi si becca il suo bicchiere in fronte!
 ma a volte non sanno come usarle, sono disorientati, nel vero senso della parola: privi di orientamento; e senza un orientamento, una direzione, un senso, anche validissimi principi e atteggiamenti relazionali, come l’ascolto e l’accettazione, vengono fraintesi e usati a sproposito.
ma a volte non sanno come usarle, sono disorientati, nel vero senso della parola: privi di orientamento; e senza un orientamento, una direzione, un senso, anche validissimi principi e atteggiamenti relazionali, come l’ascolto e l’accettazione, vengono fraintesi e usati a sproposito.






 Quindi vi consiglio di non separarli di continuo, ma di presidiare inizialmente i momenti di gioco tra di loro, e allontanatevi ogni tanto gradatamente, definendo prima un patto con Matteo “vado in cucina 10 minuti, voglio sentirvi giocare bene senza litigare”; quanto tornate e tutto è andato bene, date dei rinforzi positivi al grande. Se invece dopo 5 minuti già la piccola piange per l’ennesimo pizzico, non fatene un dramma! Correggete, ma senza interventi moraleggianti. Date di nuovo fiducia a Matteo e riprovate. A piccoli passi. E datevi tempo. Crescendo impareranno anche a giocare insieme, e vedrete che poco alla volta la gelosia lascerà spazio alla complicità positiva.
Quindi vi consiglio di non separarli di continuo, ma di presidiare inizialmente i momenti di gioco tra di loro, e allontanatevi ogni tanto gradatamente, definendo prima un patto con Matteo “vado in cucina 10 minuti, voglio sentirvi giocare bene senza litigare”; quanto tornate e tutto è andato bene, date dei rinforzi positivi al grande. Se invece dopo 5 minuti già la piccola piange per l’ennesimo pizzico, non fatene un dramma! Correggete, ma senza interventi moraleggianti. Date di nuovo fiducia a Matteo e riprovate. A piccoli passi. E datevi tempo. Crescendo impareranno anche a giocare insieme, e vedrete che poco alla volta la gelosia lascerà spazio alla complicità positiva.